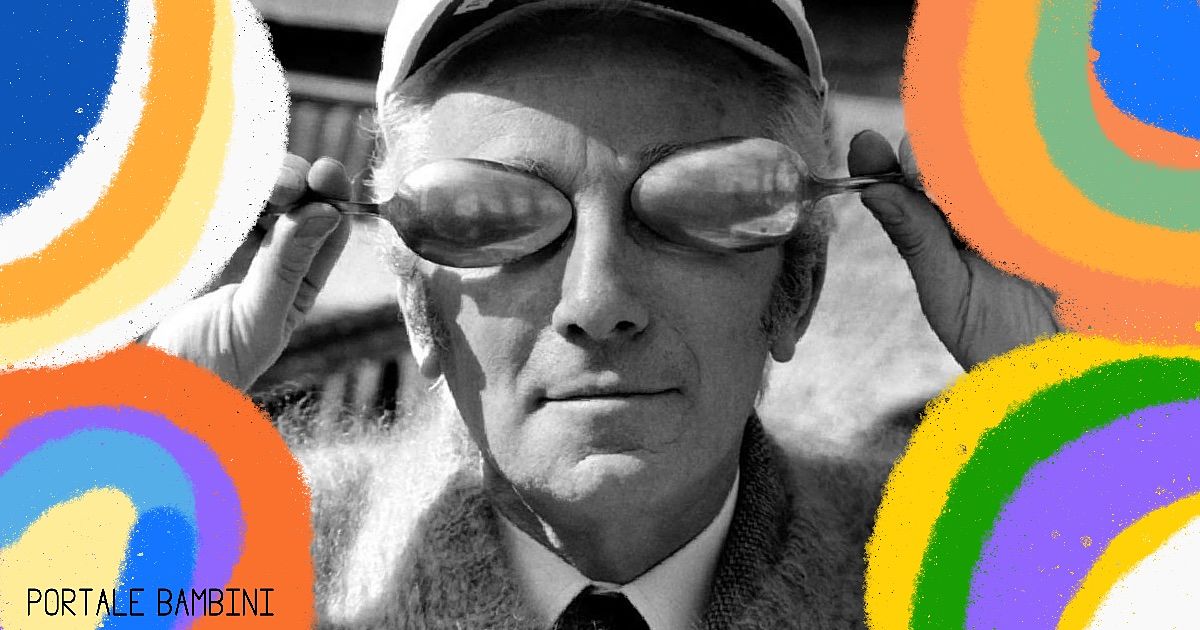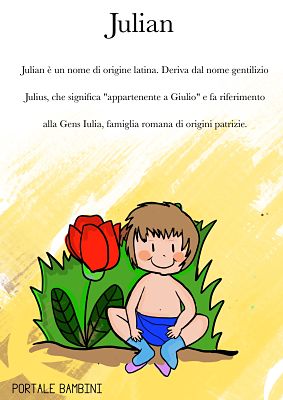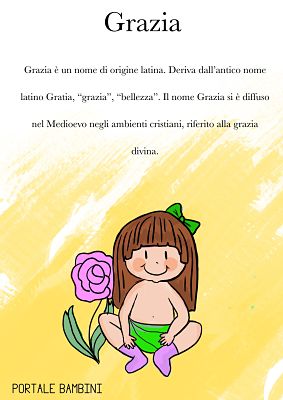Educare a pensare: le riflessioni di un’alunna di Alberto Manzi
EDUCARE A PENSARE
di Elisa Manacorda, alunna di Alberto Manzi
Ho avuto la fortuna di passare qualche anno della mia vita (dalla seconda alla quinta) con il Maestro Manzi, e sono qui per raccontarvi in prima persona quali sono le cose che dal mio personalissimo punto di vista il maestro mi ha trasmesso nelle ore passate in classe e fuori, e che ho sedimentato dentro di me. Ho fatto una lista di quattro parole chiave, che a loro volta si portano dietro concetti complessi. Alcune si ritrovano nella sua lettera che ci ha lasciato alla fine del ciclo scolastico, altre invece fanno parte della vita che abbiamo trascorso insieme, io e i miei compagni. Compagni e amici che ancora oggi formano un gruppo coeso, che ha voglia non soltanto di ricordare il passato ma anche di vivere insieme il presente.
FIDUCIA IN SE STESSI (coraggio, sicurezza)
La V A della Scuola elementare Fratelli Bandiera di Roma era una classe molto composita, in un quartiere di commercianti e media borghesia. Tra noi c’era il figlio del dirigente, quello del bancario, quello dell’intellettuale, ma anche quello del pizzicagnolo e del bidello. C’era la destra e c’era la sinistra (parliamo della fine degli anni Settanta). Qualcuno aveva più opportunità e più strumenti, qualcuno meno. Eppure questo dato incideva assai poco nella vita di noi bambini. Le lezioni del maestro avevano una caratteristica fondamentale, che oggi sembra essere persa. Si parlava moltissimo. Si discuteva tanto. E di temi difficili, alti: la democrazia, il rapporto con lo straniero (gli zingari, nel linguaggio dell’epoca). E ciascuno poteva davvero dire quello che pensava. Naturalmente avevamo opinioni molto diverse, ma le esprimevamo in libertà sapendo che nessuno sarebbe
stato preso in giro per il proprio pensiero. Erano discussioni vere, in cui nessuno sapeva dove saremmo andati a finire. Non c’era un obiettivo, o se c’era (il maestro presumibilmente lo aveva) era molto ben celato. In questo senso non importava tanto dove stessimo andando, ma la strada che stavamo facendo per raggiungere la nostra meta. Questo ci dava moltissima fiducia nelle nostre opinioni e nel nostro punto di vista. Anche il fatto di non essere etichettati con un voto alla fine del trimestre era molto importante ai fini della nostra fiducia. Naturalmente il maestro ci valutava, eccome. Ma non dava a questa sua valutazione un numero fisso. Era una valutazione variabile, che cambiava a seconda della giornata, a seconda di quello che avevamo fatto. Conoscendoci, sapeva perfettamente cosa potevamo fare e gli sforzi che ci erano necessari per andare avanti. Ma la strada era diversa per ognuno: partivamo da posizioni diverse, e rinchiudere i nostri percorsi in un numero sarebbe stata una gabbia che in alcuni casi avrebbe tolto la fiducia in noi stessi. Infine: nella lettera di fine anno c’è un riferimento molto esplicito alla fiducia in noi stessi. “Fate lavorare quel macinino del vostro cervello, perché nessuno di voi è incapace di farlo”. Nessuno. Il maestro aveva davvero una fiducia illimitata nelle nostre potenzialità. E oggi posso dire che tra noi, quelli che in una scuola normale sarebbero stati forse penalizzati oggi sono felici e realizzati professionisti.
CURIOSITÀ (autonomia, senso critico)
Anche questo è un tema importante, che io sento molto nel lavoro che faccio. Curiosità voleva dire non fermarsi all’apparenza delle cose, ma provare ad andare più a fondo, vedere le cose da un altro punto di vista, sempre. Nella lettera c’è una frase che incoraggia a “infilare le dita nelle piaghe del mondo”, e questo secondo me è il senso vero del suo insegnamento. Provare sempre a scavare, non essere superficiali, sapere che ogni cosa può avere mille sfaccettature e che la curiosità è parte integrante del senso critico. Quest’ultimo era un altro punto fondamentale: il senso critico fa sì che nessuno possa schiacciarti. C’era quindi un senso di libertà insito in
questo insegnamento, la capacità di continuare a ragionare e resistere a ogni “dittatura” intellettuale, essere sempre aperti ma saper ragionare con la propria testa. Mettersi nei panni degli altri, provare farsi domande, sempre, davanti a qualunque tema. Indagare, riflettere su un argomento, rigirarselo tra le mani prima di metterlo via.
ONESTÀ (etica, rispetto, dignità)
Questa parola, che pure è presente nella lettera di fine anno, serve a dire che la scuola del maestro era soprattutto una scuola di vita. Alberto Manzi era un trasmettitore di valori, e non di nozioni. Onestà era aderenza con quello che si era, era mancanza di ipocrisia, era coraggio delle proprie azioni. Il maestro aveva una formazione cattolica, ma onestà qui è inteso in senso laico, di dirittura morale. Era etica nelle cose che si dovevano fare, che bisognava fare bene e rispettando gli altri (esseri umani e viventi in generale). Lo studio, il lavoro, i rapporti con gli altri, tutto era improntato all’onestà, che però racchiudeva valori più grandi e più vasti. Era anche schiena dritta davanti alle avversità, era coraggio di pensare le cose in un certo modo, difendere le proprie idee, dignità propria e degli altri. Noi sapevamo che il maestro veniva punito per le sue scelte. Pagava in prima persona. E dunque questa dirittura morale, rispetto della nostra e della sua dignità è stato per noi un grande insegnamento.
LINGUAGGIO, LOGICA
Il maestro era molto attento alle parole. Era infatti narratore e traduttore, oltre che insegnante. Quando parlo di linguaggio intendo in primo luogo attenzione alla punteggiatura. Che in quegli anni e ancora oggi è stata molto trascurata. La sequenza che si vede nello sceneggiato, relativa all’arrivo dell’ispettore in classe, è vera. Il maestro scrisse sulla lavagna la frase “Il maestro, dice l’ispettore, è un asino”. Poi cambiò la punteggiatura e scrisse “Il maestro dice: l’ispettore è un asino”. Noi ci mettemmo a ridere, ma era un modo per farci capire quanto pesassero quei minuscoli segni tra le parole. Ma la sua era soprattutto attenzione a quello che davvero
volevano dire le parole. Abbiamo imparato che quando si legge un testo bisogna fare molta attenzione, e capire cosa c’è scritto davvero. Abbiamo imparato che per ogni domanda non c’è una sola risposta (penso ai test a crocette che si svolgono nelle scuole di oggi), ma molte altre, tutte ugualmente esatte. Quando ci chiedeva di descrivere a parole come ci si allacciano le scarpe o come ci si lavano i denti, era importantissimo fare attenzione a tutte le parole usate nella descrizione. È un esercizio molto difficile, riuscire a descrivere esattamente tutte le azioni che si compiono quando ci si lavano i denti. Perché teneva tanto alle parole? Perché le parole mettono in ordine i pensieri. Parlare bene, pensando a quello che si sta dicendo, usare le parole giuste e la struttura corretta, ha molto a che fare con la logica, con una struttura di pensiero solida.
BIBLIOGRAFIA
L’eredità dei grandi maestri. Storie di un passato da riscoprire per rispondere alle sfide del presente, Centro Alberto Manzi, zaffiria.it
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.
Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.