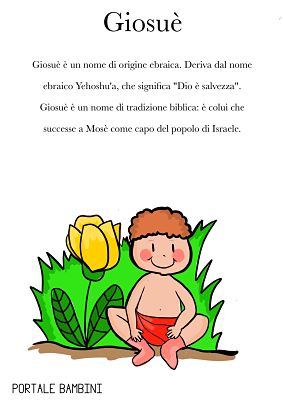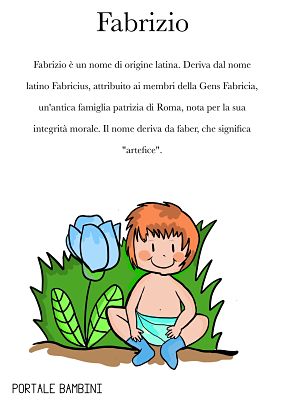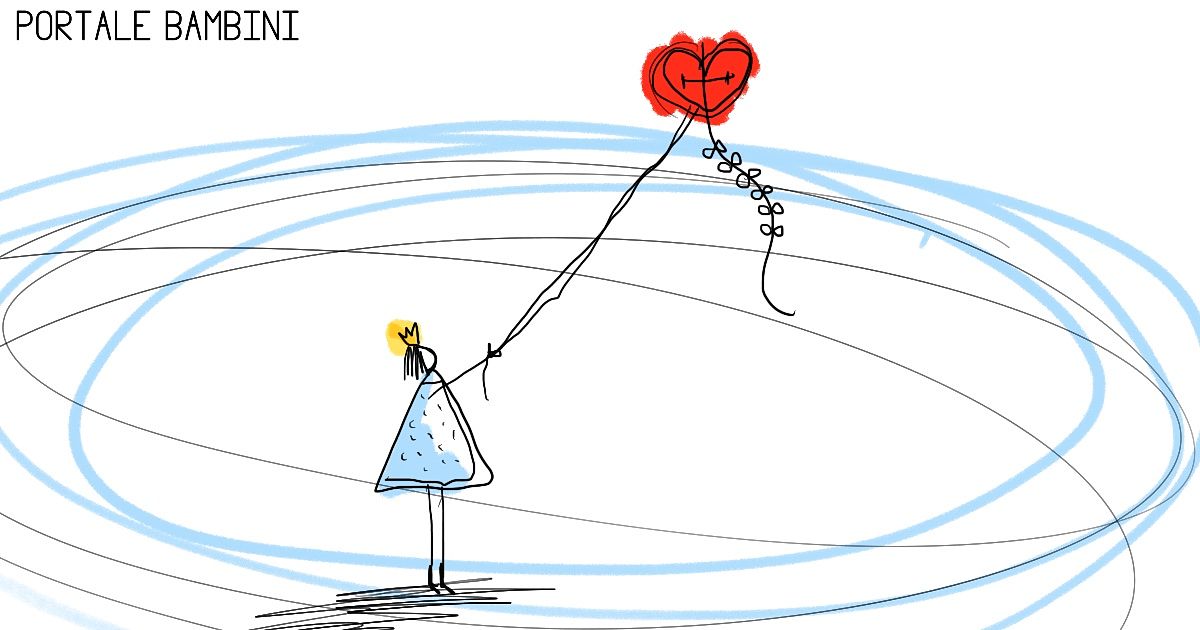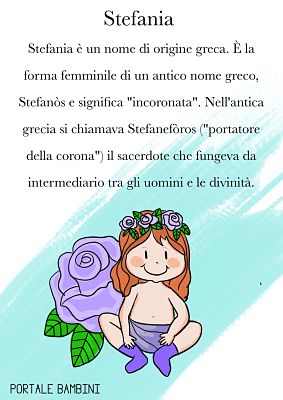Le emozioni negative
Le emozioni negative (come paura, rabbia e disgusto) ci aiutano ad evitare dei potenziali pericoli. Quando proviamo un’emozione negativa, solitamente abbiamo una reazione emotiva estremamente veloce, che precede il pensiero razionale).
Le emozioni sono un’eredità del nostro cervello “animale”, legate alla sopravvivenza. Prendiamo come esempio la paura: si attiva a velocità record quando il nostro cervello riconosce un pericolo potenziale. Quando proviamo paura, il nostro cervello ha due possibilità: scappare dalla minaccia o combattere per eliminarla.
Immaginate uno struzzo nella savana: i suoi occhi scorgono tra i cespugli un’ombra che si muove, a pochi metri da lui. Potrebbe essere un predatore. Il cervello dello struzzo è progettato per sopravvivere, così si attiva l’emozione della paura. In una frazione di secondo ecco il nostro struzzo che corre via alla velocità della luce.
Se il nostro pennuto si fosse fermato a riflettere su ciò che aveva visto, analizzando l’ombra e facendo delle ipotesi, non avrebbe avuto alcuna chance di sopravvivere.
In questo caso, la reazione – che possiamo chiamare reazione emotiva – dello struzzo è stata attivata da un’emozione primaria, la paura, e gli ha salvato la vita.
Notate che il pericolo era solo potenziale: abbiamo parlato di un’ombra tra i cespugli, non di un predatore. La paura, però, si è attivata lo stesso. Infatti, è sufficiente un ipotetico pericolo per attivare i meccanismi della paura. Questo significa che potremmo(noi come lo struzzo) provare paura e comportarci di conseguenza sulla base di un semplice sospetto.
La paura è utile anche a noi genitori e agli educatori: immaginate di vedere un bambino che si sporge da un precipizio. Potrebbe cadere e farsi molto male. Il nostro cervello, in una frazione di secondo, ci fa provare paura e guida il nostro comportamento: ed ecco la mamma che afferra bruscamente il suo bambino e lo allontana dallo strapiombo.
In casi come questo il pensiero razionale è lento e inefficace. Una reazione emotiva, al contrario, ha il giusto tempismo e ci permette di evitare efficacemente il pericolo.
Ciò che abbiamo detto a proposito della paura vale anche per le altre emozioni negative: la rabbia, ad esempio, ci aiuta ad affrontare un “nemico” che in qualche modo ci danneggia; il disgusto ci aiuta ad evitare cibi e sostanze che potrebbero rivelarsi tossiche e così via. Esistono centinaia di casi in cui una reazione emotiva immediata è utile per la sopravvivenza quotidiana.
Anche la rabbia ha una funzione precisa: ci permette di difenderci da un pericolo cercando di distruggerlo.
Purtroppo, le emozioni negative possono incidere negativamente sulle nostre relazioni. Le reazioni emotivo-sentimentali negative sono la causa principale dell’inquinamento sociale e dei suoi frutti (siano essi uno scarso coinvolgimento a scuola o una forma di disagio in famiglia). Queste reazioni non sono immediate; seguono un’emozione negativa, ma sono il frutto della nostra scelta deliberata di dare sfogo alla nostra frustrazione. Ecco qualche esempio di reazione emotivo-sentimentale negativa.
- “Perché non presti mai i tuoi giocattoli a tuo fratello? Sei un’egoista. Pensa a tutte le cose che noi facciamo per te; tu, invece, non fai altro che chiedere e pretendere. Dovresti vergognarti”.
- “Non hai studiato neanche una pagina. Sei il più pigro e svogliato della classe. Se continui così, non combinerai mai nulla nella vita”.
- “Basta. Non riesci a giocare due minuti da solo senza disturbare noi adulti! Sei davvero fastidioso. Adesso vai in camera e lasciaci in pace”.
PER EDUCARE CON LE FAVOLE:
Per aiutare i più piccoli a riconoscere le emozioni e a coltivare le buone pratiche che ci fanno stare meglio abbiamo scritto la raccolta di racconti “Cuorfolletto e i suoi amici”.
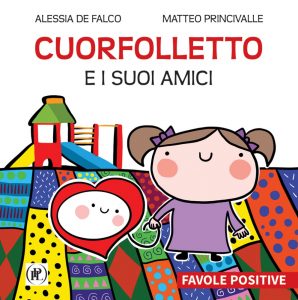
TORNA A:
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.
Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.