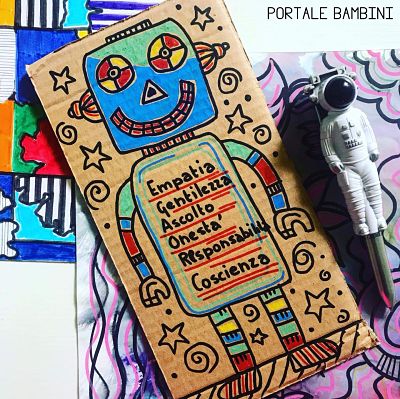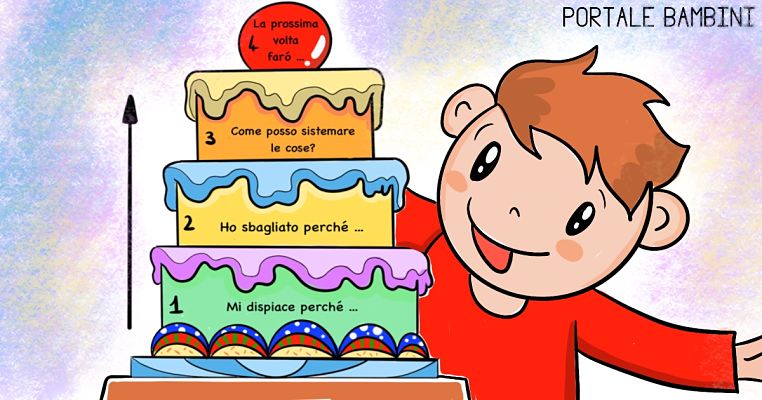Nel 60 a.C. a Roma erano tre gli uomini politici influenti:
- Caio Giulio Cesare, nipote di Mario e leader dei popolari;
- Pompeo, condottiero che aveva riportato grandi vittorie in Asia e nel Mediterraneo contro i pirati;
- Crasso, generale che aveva sconfitto Spartaco; Crasso era un uomo ricchissimo, che aveva fatto fortuna sequestrando i beni confiscati ai nemici politici di Silla, inseriti nelle liste di proscrizione.
Questi tre uomini, nel 60 a.C. formarono un triumvirato, ovvero un accordo per governare senza contrasti. L’accordo prevedeva che Pompeo e Crasso avrebbero sostenuto la candidatura di Cesare come console. In cambio, Cesare avrebbe approvato una legge per distribuire le terre ai veterani di Pompeo e per garantire a Crasso e ai suoi cavalieri la gestione degli appalti pubblici a Roma.
Cesare, Crasso e Pompeo stipularono segretamente questo accordo, che prese il nome di primo triumvirato, a Lucca.
Cesare mantenne i patti e, inoltre, si fece assegnare i territori della Gallia Cisalpina (l’Italia settentrionale), della Gallia Narbonense (Francia meridionale) e dell’Illiria.
Si trattava di province povere, poste ai confini del territorio romano. Cesare le aveva scelte proprio per questa ragione: erano poco ambite dagli altri uomini politici e gli avrebbero permesso di conquistare i territori confinanti, guadagnandosi il supporto dell’esercito.
Prima di partire per la Gallia, Cesare eliminò da Roma i suoi principali nemici politici: Cicerone e Catone. Cicerone fu esiliato per aver violato le leggi di Roma, Catone fu inviato sull’isola di Cipro con un modesto incarico politico.
Tra il 58 a.C. e il 56 a.C. Cesare guidò l’esercito alla conquista della Gallia, territorio che oggi corrisponde alla Francia e a parte della Germania. Cesare approfittò del fatto che i Germani, popolazione venuta dal Nord, stavano attaccando i villaggi dei Galli. In questo modo, l’esercito romano riuscì ad allearsi con molte tribù galliche, mettendo insieme una forza militare notevole. In due anni sbaragliò i nemici e conquistò un territorio immenso.
Le vittorie sul campo e l’abile utilizzo della diplomazia resero Cesare un comandante vittorioso e stimato. Tuttavia, il Senato gli era avverso, poiché rappresentava il fronte dei popolari.
Al suo rientro a Roma, Cesare rinnovò il patto con Pompeo – che invece godeva del supporto del Senato – e con Crasso; il generale, infatti, aveva bisogno di altri cinque anni per sottomettere tutte le Gallie e mentre era impegnato nella sua campagna di conquiste aveva bisogno di una situazione politica stabile a Roma.
Cesare tornò in Gallia; tra il 56 a.C. e il 51 a.C. riuscì nella sua impresa di conquista: tutti i territori abitati dai Galli vennero romanizzati. Il generale si spinse in Britannia, dove sottomise le popolazioni locali imponendo pesanti tributi. Nel 51 a.C. tornò a Roma con le sue legioni vittoriose.
Nel frattempo, Crasso era morto in Siria, ucciso dai Parti e il Senato, per contrastare la figura di Cesare, aveva nominato Pompeo console senza collega, una novità per la repubblica di Roma. Pompeo, in sostanza, rivestiva l’incarico di console ma aveva pieni poteri, alla pari di un dittatore. Pompeo approfittò dei suoi poteri per far richiamare Cesare a Roma, togliendogli il governo delle province che aveva conquistato.
Cesare decise di opporsi a questa decisione: tornò a Roma, ma non lo fece come privato cittadino; marciò insieme alle sue legioni, con l’intenzione di muovere guerra a Pompeo. Quando i soldati attraversarono il fiume Rubicone, in Romagna, scoppiò la seconda guerra civile nella storia della repubblica di Roma (la prima era stata quella scatenata da Silla).
Pompeo, tuttavia, non era preparato ad affrontare Cesare e i suoi legionari e fuggì in Grecia, insieme ad un gruppo di senatori. Cesare entrò a Roma e costituì un nuovo governo, assumendo la carica di console insieme a un uomo di fiducia. Poi, sbarcò in Grecia dove sconfisse duramente Pompeo, a Farsalo (nel 48 a.C.). Pompeo fuggì in Egitto, dove il re Tolomeo lo fece assassinare; con questa mossa, il re sperava di ottenere la simpatia di Cesare. Ma Cesare, invece di premiarlo, lo fece deporre e nominò Cleopatra, sorella di Tolomeo, regina d’Egitto.
Con il governo di Cleopatra anche l’Egitto divenne un’area controllata da Roma. Da lì, Cesare inseguì i figli di Pompeo e i suoi nemici politici in Africa, dove furono sconfitti a Tapso. Cesare approfittò delle vittorie in Africa per conquistare nuovi territori e costituire la provincia Africa Nova.
I pompeiani erano stati sconfitti in più occasioni e i pochi superstiti si rifugiarono in Spagna, dove Cesare li sconfisse un’ultima volta, a Munda. Con la battaglia di Munda, nel 54 a.C. si concluse la seconda guerra civile.
Con la fine della seconda guerra civile, Cesare trasformò la repubblica di Roma in una monarchia: assunse il pieno potere politico ed esecutivo. Il Senato gli aveva conferito la carica di dictator per dieci anni, ma Cesare istituì una nuova carica, quella di imperator. L’imperator aveva i pieni poteri consolari, fungeva da tribuno della plebe e da pontefice massimo, oltre ad essere a capo dell’esercito; questa carica, inoltre, veniva mantenuta a vita.
Cesare, tuttavia, non si comportò da tiranno e non perseguitò i suoi nemici; al contrario, fu benevolo con tutti i nobili e i senatori pompeiani che avevano deciso di accettare la sua autorità. La sua intenzione era quella di conquistarsi così il favore del Senato e dei patrizi. Durante il suo impero, Cesare inviò molti uomini nelle colonie, assegnò terre ai veterani, aumentò il numero dei senatori e riformò il sistema della giustizia. Tra i progetti politici dell’imperator c’era la volontà di eliminare la differenza netta tra Roma e le province, concedendo la cittadinanza e pieni diritti a tutti gli abitanti dei territori più lontani da Roma.
Questi progetti non erano benvisti dai senatori, che vedevano nell’estensione dei diritti la fine della supremazia di Roma; fu organizzata una congiura per assassinare Cesare e ripristinare l’oligarchia che aveva caratterizzato la repubblica. Il 15 marzo del 44 a.C. Cesare fu assassinato mentre entrava in Senato. Tra i suoi assassini c’era anche Bruto, suo figlio adottivo.
Schede di storia:
🔴 Storia – Classe prima
🟠 Storia – Classe seconda
🟡 Storia – Classe terza
🟢 Storia – Classe quarta
🔵 Storia – Classe quinta
↩️ Storia – Tutte le schede
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.