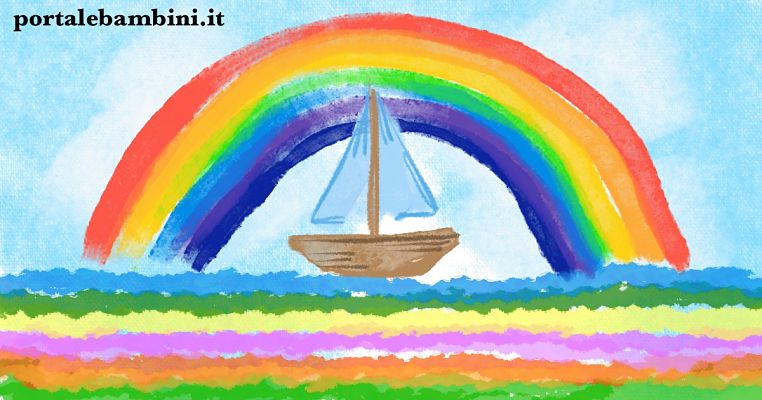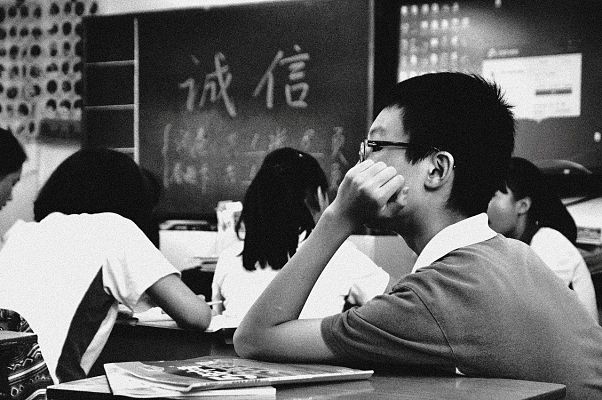Siamo tutti “Specialmente Normali”: l’educazione deve abbandonare l'”idealtipo medio”

L’educazione è sempre speciale. L’idea che esistano “bisogni educativi normali” e “bisogni educativi speciali” è pericolosa e discriminante, perché, a ben guardare, vi sono molti più “bisogni speciali” di quanti non se ne rilevino attraverso un test.
Come dovremmo considerare quegli studenti “normali” che soffrono però di seri deficit nell’autostima? E quelli ai quali manca la motivazione? E gli studenti, sempre “normali”, che versano in stati più o meno gravi di analfabetismo emotivo? Per la scuola, così com’è progettata, sono fantasmi. Ad oggi esiste una frattura importante tra il curricolo scolastico e la vita reale, frattura che per alcuni ragazzi trasforma il percorso scolastico in un calvario e che per altri si traduce, più tardi, in una forma grave di “analfabetismo alla vita”.
Ecco perché ci piace parlare di speciale normalità. L’ha definita bene Dario Ianes: “La speciale normalità è una condizione di sintesi tra specialità e normalità, che le contiene e le supera entrambe: la normalità si arricchisce di specificità non comuni, di peculiarità, di risposte tecniche particolari; la specialità va ad arricchire le normali prassi, ne penetra le fibre più profonde e le modifica, le rende più inclusive e rispondenti ai bisogni. Più in generale, nella speciale normalità troviamo condizioni miste, intrecciate, che presentano aspetti diversi: alunni normali che possiedono molti tratti di specialità, alunni speciali con i bisogni essenziali della normalità, risposte speciali che trasformano la normalità e in questo cessano di essere tali, e così via“.
Questo significa che il percorso formativo di ciascuno di noi deve essere speciale, la “speciale normalità” è il requisito necessario perché questa formazione abbia un senso. L’educazione, per funzionare, deve costituire un potenziamento della normalità, non un allontanamento da essa. Dobbiamo evitare la tentazione di costruire “stereotipi”, modelli ideali che saranno sempre e comunque modelli idealtipici medi. Questi modelli non sono d’aiuto a nessuno di noi e anzi, potrebbero danneggiare grandemente qualcuno.
BIBLIOGRAFIA
Ianes D. (2006), La speciale normalità, Erickson
Ianes D. Integrazione scolastica: un intreccio tra speciale e normale, “Rassegna” dell’Istituto Pedagogico Provinciale di Bolzano, Anno XI, agosto 2003
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.
Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.