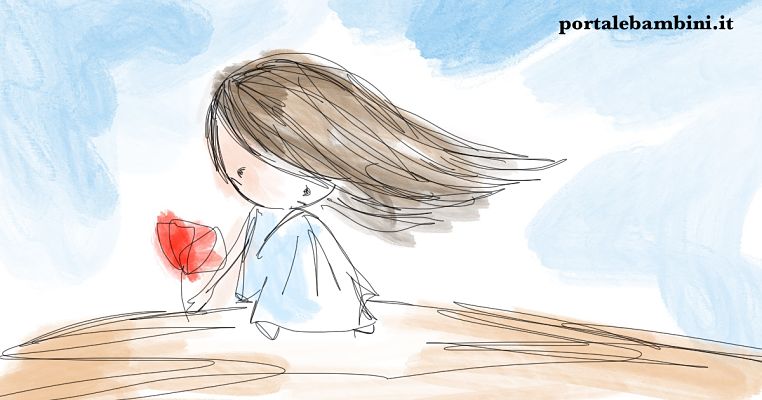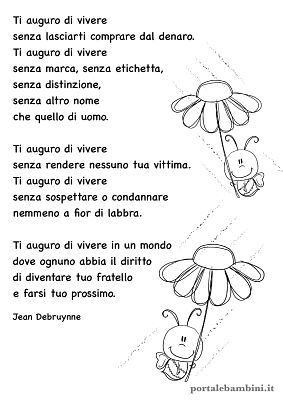Il Giorno della Memoria. Una sfida pedagogica
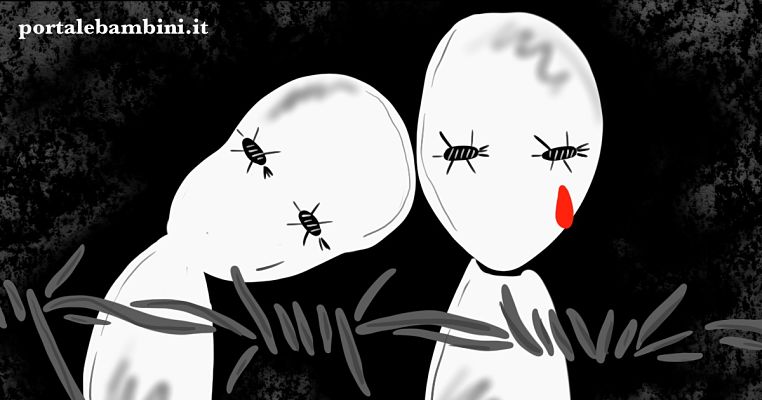
Il Giorno della Memoria ricorre il 27 gennaio di ogni anno, in ricordo del 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Questa importante ricorrenza è stata istituita per legge e rappresenta una grande sfida pedagogica per gli insegnanti e gli educatori.
In questa pagina abbiamo raccolto alcuni spunti per una didattica della Shoa trasparente ed efficace, con la speranza che attraverso la memoria si possa forgiare il futuro.
Didattica della Shoa
Perché insegnare la Shoa? Addentrarsi con lucidità nella complessità di questi eventi è un’operazione significativa in riferimento al presente, nel tentativo di sviluppare gli anticorpi necessari per riconoscere e combattere le nuove manifestazioni di discriminazione, sopraffazione, razzismo e risorgente antisemitismo, come sappiamo – purtroppo – ancora oggi in agguato; per capire come l’intolleranza verso qualcuno sia
sempre sintomo di un’intolleranza e di una violenza più generalizzata. Scomporre il passato e cercare di comprenderlo aiuta a capire e vivere il presente. È un modo per imparare ad esercitare nella nostra società una cittadinanza attiva e consapevole. Sappiamo bene che la democrazia senza educazione non si regge. La si impara studiando e vivendo.
Come insegnare la Shoa? La moderna pedagogia e l’esperienza didattica internazionale hanno individuato per i bambini delle scuole primarie modalità di approccio graduali e non traumatiche, che privilegino vicende in cui i protagonisti si salvano, testimoniando valori positivi di speranza e fiducia negli altri e nella vita.
Rimettere al centro gli individui – L’International School for Holocaust Studies (un settore del centro studi Yad Vashem di Gerusalemme) considera prioritario che qualsiasi percorso di studio sulla Shoah ponga al centro dei suoi obiettivi formativi ed etici il principio di salvare ogni individuo dall’anonimato.
Proprio in riferimento all’incontenibile numero di persone brutalmente eliminate e al rischio che questo possa condurre ad una percezione non corretta di quanto accaduto, la proposta pedagogica di Yad Vashem è quella di focalizzare l’attenzione sulla storia di vita di ogni singola persona, sulla famiglia e sulle caratteristiche socio-culturali delle comunità ebraiche che sono state spazzate vie dalla bufera distruttrice nazifascista.
È sempre necessario considerare il dramma della Shoah, restituendo alle vittime la dignità di esseri umani unici e irripetibili, con un volto, un corpo, con pensieri, desideri, passioni, aspettative, con la loro rete di relazioni interpersonali. Lo studio del cambiamento dei sistemi di vita delle persone in prossimità degli eventi permette di rimanere dentro la dimensione umana della Shoah e di costruire degli strumenti di comprensione della realtà, anche attuale, di fondamentale importanza.
[…]
Sono molte le storie che possono essere presentate a questo riguardo. Le storie dei sopravvissuti ci trasmettono una grande forza di volontà e il profondo desiderio di tornare alla vita facendo ogni sforzo per mettere da parte il male subito e ricostruire ciò che il nazifascismo aveva distrutto. Ci sono molteplici possibilità di raccogliere, ascoltare e fare uso didattico/educativo delle testimonianze come storie di vita.
FONTI
Linee Guida Nazionali per una didattica della Shoa a scuola, su miur.gov.it
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.
Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.