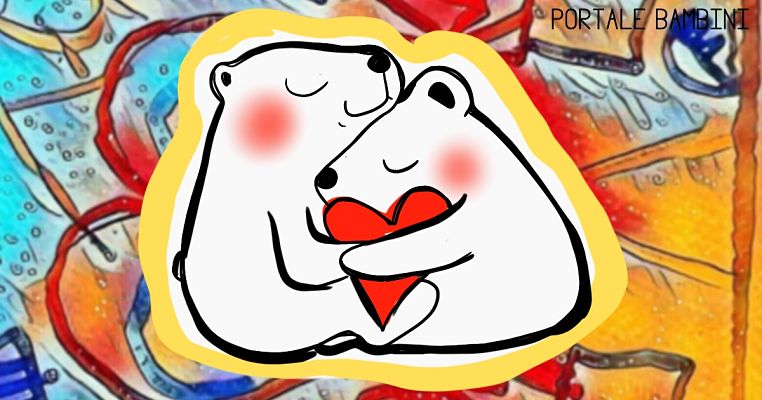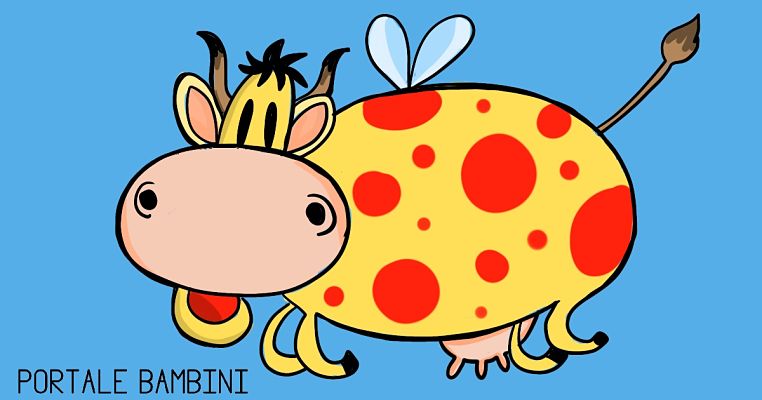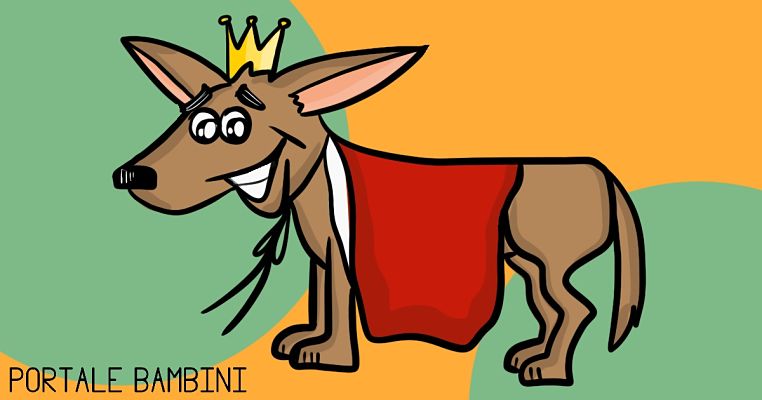LE 8 R DELLA DECRESCITA E IL LORO VALORE EDUCATIVO
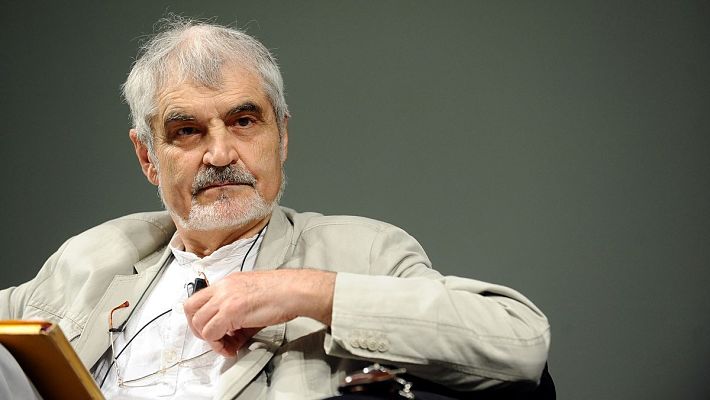
Lettura scelta, tratta da un intervento di Serge Latouche:
La “società della decrescita” presuppone, come primo passo, la drastica diminuzione degli effetti negativi della crescita e, come secondo passo, l’attivazione dei circoli virtuosi legati alla decrescita: ridurre il saccheggio della biosfera non può che condurci ad un miglior modo di vivere. Questo processo comporta otto obiettivi interdipendenti, le 8 R: rivalutare, ricontestualizzare, ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Tutte insieme possono portare, nel tempo, ad una decrescita serena, conviviale e pacifica.
- Rivalutare. Rivedere i valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita, cambiando quelli che devono esser cambiati. L’altruismo dovrà prevalere sull’egoismo, la cooperazione sulla concorrenza, il piacere del tempo libero sull’ossessione del lavoro, la cura della vita sociale sul consumo illimitato, il locale sul globale, il bello sull’efficiente, il ragionevole sul razionale. Questa rivalutazione deve poter superare l’immaginario in cui viviamo, i cui valori sono sistemici, sono cioè suscitati e stimolati dal sistema, che a loro volta contribuiscono a rafforzare.
- Ricontestualizzare. Modificare il contesto concettuale ed emozionale di una situazione, o il punto di vista secondo cui essa è vissuta, così da mutarne completamente il senso. Questo cambiamento si impone, ad esempio, per i concetti di ricchezza e di povertà e ancor più urgentemente per scarsità e abbondanza, la “diabolica coppia” fondatrice dell’immaginario economico. L’economia attuale, infatti, trasforma l’abbondanza naturale in scarsità, creando artificialmente mancanza e bisogno, attraverso l’appropriazione della natura e la sua mercificazione.
- Ristrutturare. Adattare in funzione del cambiamento dei valori le strutture economico-produttive, i modelli di consumo, i rapporti sociali, gli stili di vita, così da orientarli verso una società di decrescita. Quanto più questa ristrutturazione sarà radicale, tanto più il carattere sistemico dei valori dominanti verrà sradicato.
- Rilocalizzare. Consumare essenzialmente prodotti locali, prodotti da aziende sostenute dall’economia locale. Di conseguenza, ogni decisione di natura economica va presa su scala locale, per bisogni locali. Inoltre, se le idee devono ignorare le frontiere, i movimenti di merci e capitali devono invece essere ridotti al minimo, evitando i costi legati ai trasporti (infrastrutture, ma anche inquinamento, effetto serra e cambiamento climatico).
- Ridistribuire. Garantire a tutti gli abitanti del pianeta l’accesso alle risorse naturali e ad un’equa distribuzione della ricchezza, assicurando un lavoro soddisfacente e condizioni di vita dignitose per tutti. Predare meno piuttosto che “dare di più”.
- Ridurre. Sia l’impatto sulla biosfera dei nostri modi di produrre e consumare che gli orari di lavoro. Il consumo di risorse va ridotto sino a tornare ad un’impronta ecologica pari ad un pianeta. La potenza energetica necessaria ad un tenore di vita decoroso (riscaldamento, igiene personale, illuminazione, trasporti, produzione dei beni materiali fondamentali) equivale circa a quella richiesta da un piccolo radiatore acceso di continuo (1 kw). Oggi il Nord America consuma dodici volte tanto, l’Europa occidentale cinque, mentre un terzo dell’umanità resta ben sotto questa soglia. Questo consumo eccessivo va ridotto per assicurare a tutti condizioni di vita eque e dignitose.
- Riutilizzare. Riparare le apparecchiature e i beni d’uso anziché gettarli in una discarica, superando così l’ossessione, funzionale alla società dei consumi, dell’obsolescenza degli oggetti e la continua “tensione al nuovo”.
- Riciclare. Recuperare tutti gli scarti non decomponibili derivanti dalle nostre attività.
SUGGERIMENTO: Prova a leggere queste 8 R in chiave educativa: prova ad immaginarle al di fuori del contesto economico, come fondamentali di una nuova visione pedagogica per un mondo – finalmente – libero.
FONTI
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.
Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.