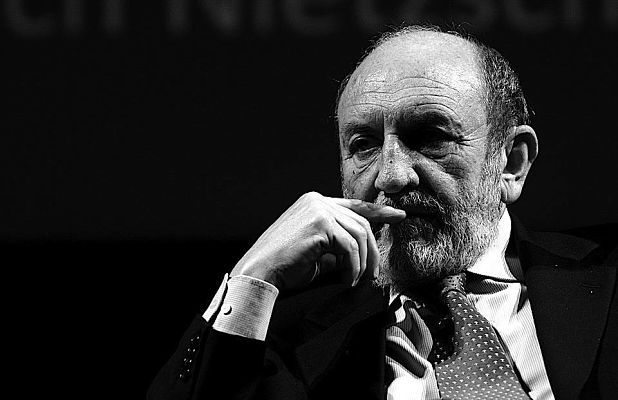Per far leggere i ragazzi occorrono genitori-lettori

È vero che i nostri ragazzi dovrebbero leggere di più? Secondo i dati Istat, sono proprio i ragazzi – superati unicamente dagli anziani – i lettori forti del paese: il 12,7% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni legge almeno un libro al mese, mentre la percentuale di lettori tra i loro genitori (fascia di età 25-55 anni) cala drasticamente.
Ereditarietà della lettura
L’abitudine alla lettura è un fattore ereditario: l’80% dei ragazzi che provengono da una famiglia in cui madre e padre sono lettori forti (coloro che leggono almeno un libro al mese) diventano lettori a loro volta.
Tra coloro che crescono in una famiglia in cui mamma e papà non leggono, invece, solo il 36% si dedica alla lettura. La metà (con una certa dose di semplificazione statistica).
A prima vista, si potrebbe liquidare la questione sostenendo che giovani e anziani leggono perché hanno tempo libero, che manca a chi lavora. Però, è proprio nella fascia di età tra i 25 e i 55 anni che troviamo coloro che trascorrono più tempo sui social network; non è il tempo a mancare, ma l’intenzione. La “vecchia scuola” non è stata capace di educare al piacere della lettura e dell’esercizio del pensiero critico. Critichiamo il sistema attuale, ma i suoi precedenti non erano certo migliori. I benefici della scuola tradizionale andrebbero circoscritti all’aura di disciplina e compostezza, quella sì.
Tuttavia, si tratta di una disciplina illusoria: i genitori di oggi, non appena si sono liberati di quella scuola e di quel rigore, si sono guardati bene – o almeno la maggior parte di loro – dalla lettura, dalla cultura e dall’impegno intellettuale. La disciplina, al contrario, è uno stato mentale di profondo coinvolgimento, di attività e di raggiungimento degli obiettivi. Un buon esempio di disciplina applicata? Sono proprio i lettori.
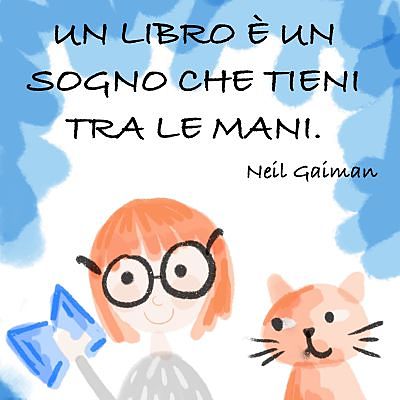
Rieducare gli adulti alla lettura
I dati che abbiamo discusso ci offrono due punti di vista: il primo è quello centrato sui ragazzi. Se la percentuale di ragazzi lettori è consistente, parte del merito va attribuito alle politiche di educazione alla lettura che – pur se insufficienti – ci sono.
Il secondo è quello centrato sui genitori. Se, come abbiamo visto, è possibile attribuire alla lettura i caratteri dell’ereditarietà, perché non lanciare una grande campagna di rieducazione alla lettura rivolta agli adulti e, in particolare, ai genitori? I risultati sarebbero doppi, a cascata: trasformando mamma e papà in lettori, si produrrebbe un effetto consistente anche sui ragazzi.
FONTI
Non avete trovato il contenuto che stavate cercando? Chiedetecelo: ogni mese realizziamo i materiali più richiesti dai lettori! Ecco il modulo per le nuove richieste: Chiedi un contenuto.
Iscrivetevi alla Newsletter o al canale Telegram per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal sito.